Né Oriente Né Occidente, recensione di Vaifra Palanca
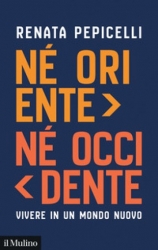
Il libro di Renata Pepicelli va controcorrente rispetto all'attuale linguaggio pubblico che sembra converegere sull'apparente inarrestabilità dei nazionalismi, suprematismi e interessi particolari a scapito del bene comune.
L’ultimo libro di Renata Pepicelli, Né Oriente Né Occidente, appena pubblicato, è un libro controcorrente che, in un periodo in cui il linguaggio pubblico, a livello nazionale e internazionale, sembra convergere sul rafforzamento dei nazionalismi, suprematismi, sulla ricerca di interessi particolari a scapito del bene comune, sull’esaltazione delle identità culturali, religiose “autentiche”, ci spiega che tutto ciò non esiste più. Alzare muri, chiudere frontiere, fermare la circolazione delle merci e delle persone non serve, è semplicemente velleitario, perché è troppo tardi. Viviamo già in un mondo “nuovo”, globalizzato nel quale Oriente e Occidente si intrecciano, ogni persona, ogni nucleo famigliare, ogni comunità, ogni Paese, per scelta o meno, è il prodotto della storia, di culture, tradizioni e filosofie che richiamano mondi solo apparentemente lontani nel tempo e nello spazio. Il benessere, la tecnologia, lo sviluppo della conoscenza hanno favorito l’incontro e le relazioni tra persone, tra popoli, rendendo possibile l’abbattimento di barriere culturali, linguistiche, religiose, valoriali, rendendo tutti più ricchi nella diversità.
Il libro si articola in cinque capitoli: 1. L’invenzione; 2. Terre e donne di conquista; 3. Ancora contrapposti; 4. Il mondo nuovo; 5. Islam, passaggio a Occidente. Conclusioni. Occiriente. Ho voluto citare la struttura e i titoli dei vari capitoli perché delineano il percorso attraverso il quale l’autrice giunge a definire una nuova area geografica, geopolitica, scaturita dalla contaminazione tra Occidente ed Oriente, ritenuti termini obsoleti, chiamata appunto Occiriente.
Renata Pepicelli, grazie alla sua conoscenza del mondo arabo e dell’Islam, alle sue ricerche sulle comunità musulmane in Italia e in altri Paesi, ci propone un’affascinante riflessione su che cosa sono oggi l’Occidente e l’Oriente, quali sono i confini di queste aree, quali le rispettive identità, con uno sguardo attento a destrutturare convinzioni, definizioni e punti di vista consolidati. Un’impresa non facile, resa tuttavia possibile attraverso l’esplicitazione delle categorie che ispirano la lettura e la decodificazione, in una prospettiva decoloniale e di genere, di situazioni, eventi, luoghi, comportamenti noti a tutti. Si tratta di un libro riuscito, scritto con rigore accademico ma con un fine divulgativo.
Il libro parla di Occidente, “cristiano” evoluto, progressista, e di Oriente, “musulmano”, retrogrado, oppressivo, così come sono rappresentati nell’immaginario occidentale, due mondi considerati contrapposti, che stanno progressivamente scomparendo.
Occidente, Oriente, Medio Oriente e Estremo oriente, sono solo apparentemente definizioni geografiche neutre e oggettive, in realtà, ricorda Pepicelli, sono termini coniati nel XIX secolo quale “prodotto di portati storici, culturali, politici”, “ termini eurocentrici, nati per descrivere il mondo attraverso gli occhi dei colonizzatori europei che, mediante tali denominazioni, suddividevano e ricreavano il globo in regioni funzionali alle proprie necessità di dominio, affermando una volontà, che si perpetua nel tempo e nello spazio, di catalogazione e controllo di territori e popoli” (pag. 27). Le crociate, il colonialismo, una narrazione esotica di viaggiatori e scrittori, hanno concorso ad alimentare una visione dell’Oriente cristallizzata a dei parametri culturali, sociali che le migrazioni, i movimenti per i diritti civili, i movimenti femministi hanno sconvolto.
La dimensione religiosa è fondamentale, è la principale chiave di lettura, nella riflessione di Renata Pepicelli per delineare le caratteristiche delle diverse aree e, appunto, la contrapposizione tra Occidente cristiano e Islam. Particolare attenzione viene dedicata al mondo islamico e, al suo interno, alla condizione femminile, sottolinenando la complessità e la diversità esistente tra Paesi che si definiscono musulmani, sia per forme di governo, che per le libertà garantite, per i livelli di benessere. In questo contesto vengono analizzati, senza indulgenza, anche movimenti islamisti che hanno causato morte e distruzione.
Come ha fatto in altri suoi libri, ha approfondito l’aspetto del velo e dell’abbigliamento femminile, senza giudicare, ma anzi riconoscendo dignità a comportamenti che denunciano un attaccamento alla propria cultura, ai propri costumi e tradizioni, spesso, come appunto avviene per il velo, in difesa della propria identità contro l’Occidentalizzazione. Cita, inoltre, il ruolo di donne intellettuali (Fatema Mernisi), politiche (Hoda Sha’rawi) che nei rispettivi Paesi hanno portato avanti discorsi in difesa dei diritti delle popolazioni e in particolare delle donne. In contrapposizione, approfondisce il discorso sulla rappresentazione artistica delle donne d’Oriente da parte di artisti occidentali, alcuni dei quali non sono mai andati in oriente, donne che, se nella realtà sono considerate sottomesse, confinate in ambiti domestici, vengono rappresentate nelle loro nudità, in posizioni ammiccanti e lascive secondo l’immaginario della cultura occidentale.
Con riferimento al mondo arabo e all’Islam, sottolinea come ci sia stato un tempo in cui la cultura araba abbia reso splendenti le nostre isole in un clima culturale di reciproco apprezzamento. Ricorda come sotto il regno di Ruggero II, re Normanno, all’inizio dell’anno Mille, Palermo abbia vissuto un periodo di cosmopolitismo e fervore culturale, ma anche un periodo di grande splendore artistico e architettonico, grazie alle maestranze arabe presenti e alla forte influenza di stili orientali. Fu in questo periodo che, su commissione di Ruggero II, il geologo Muhammad al-Idris, marocchino di origine, realizzò la Tabula Rogeriana, un planisfero costituito da 70 mappe d’argento rappresentanti il mondo, che assumevano come punto di osservazione la penisola arabica, quindi la Mecca, risultando agli occhi degli occidentali, abituati a guardare il mondo dal punto di vista eurocentrico, capovolte.
Anche in Italia è necessario scoprire come ormai più di 50 anni di immigrazione, scambi culturali con Paesi di tutto il mondo, abbiano prodotto profondi cambiamenti nel costume, nel modo di pensare, nella geografia umana. Al di là dei numeri riportati dai vari report sull’immigrazione, Renata Pepicelli sottolinea, all’interno della popolazione di origine immigrata, la presenza di comunità arabo-islamiche, con i loro costumi, i loro luoghi di culto, le loro cucine, ma che nello stesso tempo partecipano alla vita dei luoghi in cui vivono generando aree di contaminazione, di sincretismo irreversibili. Sono questi i segni del cambiamento che delineano il profilo culturale e sociale del mondo del futuro e che mettono in discussione l’idea di italianità, purtroppo fatto non compreso dall’attuale Ministro dell’istruzione, non ridimensionata, non arroccata nel suo passato, ma arricchita di nuove opportunità. Che dire di Rafsana e Raseda, nate in Italia da genitori Bengalesi, trasferitesi a Londra con la famiglia dove l’una insegna in una scuola londinese dopo studi all’Università, l’altra è astrofisica consulente in una società, entrambe con l’Italia e il Pigneto nel cuore e nei pensieri.
Che dire inoltre di intellettuali, di classe dirigente, conosciute per la loro professione, i loro successi letterari (es. Igiaba Scego) oltre che per la loro storia, che vivono in Italia, con una grande consapevolezza della storia, della letteratura, tanto da farne una professione, ma interpellate spesso come se fossero straniere perché non corrispondenti ai canoni somatici dell’italianità. Ma anche di tante persone provenenti da altri paesi o figli dell’immigrazione, che vivono la quotidianità con il loro lavoro, lo studio, con i sacrifici, con i loro riti e culti, come tanti italiani, che si sentono italiani e sono italiani, perché qui è la loro casa.
Basta guardare le scuole nelle quali la presenza di bambini figli di famiglie di origine straniera è costantemente in aumento, bambini che imparano sin da piccoli a guardare la realtà da più punti di vista, che osservano un mondo dagli orizzonti più ampi, che si sentono protagonisti nella loro scuola, nella squadra di calcio del territorio, che hanno amicizie e amori al di là delle differenze, al di là della “linea del colore”. Emblematica in questo contesto è stata la decisione del consiglio di istituto della scuola “Iqbal Masih” di Pioltello in provincia di Milano, di considerare giorno festivo il giorno di chiusura del Ramadan, perché in quella scuola il 42% degli alunni è di religione musulmana e quel giorno non avrebbe potuto frequentare le lezioni. Una scelta razionale, a tutela della didattica e nel rispetto del sentimento religioso di gran parte degli alunni e delle loro famiglie, che ha suscitato però tanta indignazione e discussioni.
Questo è il nuovo mondo. È l’Occiriente. Nuovi cittadini abitano e vivono l’Oriente e l’Occidente. Qui non c’è invasione da parte dell’Islam né da parte di altre popolazioni, ma ci sono persone, che hanno nomi con suoni diversi, praticano religioni diverse, parlano anche lingue diverse, che vogliono vivere qui con gli stessi diritti e gli stessi doveri della maggioranza della popolazione.
Vaifra Palanca
Renata Pepicelli, Né Oriente né Occidente. Vivere in un mondo nuovo, il Mulino, Bologna 2025, 16,00 Euro
09 aprile 2025